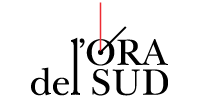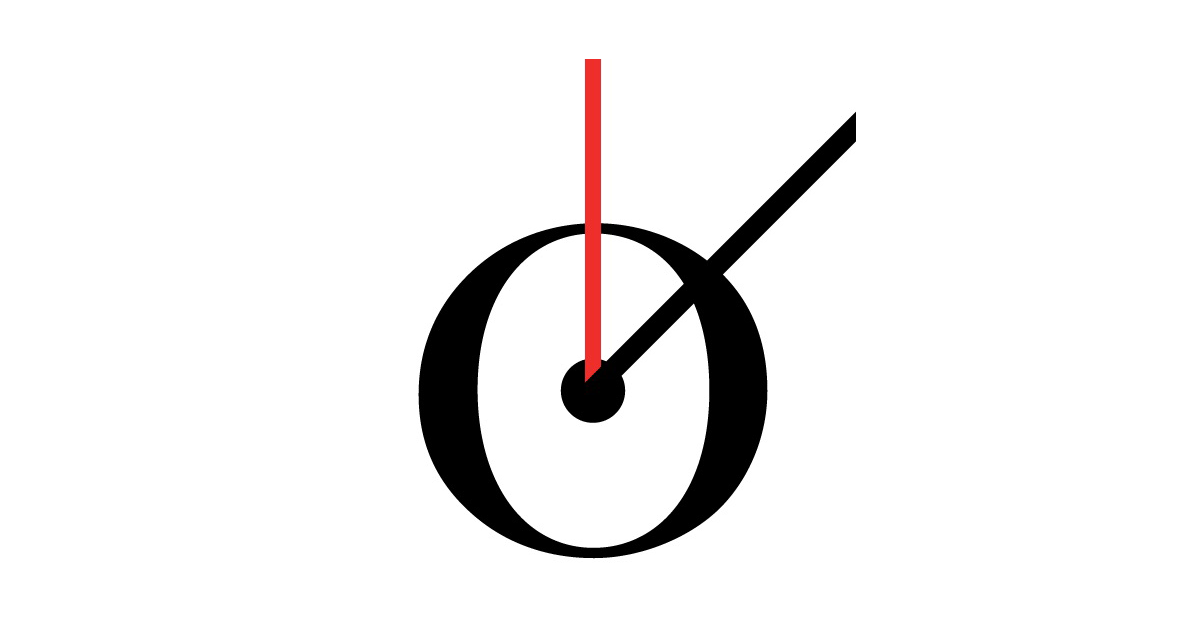La decrescita infelice del Sud e i compiti dello Stato
LUIGI PANDOLFI
Banconote da 50, 20, 10 e 5 euro
Il ritardo infrastrutturale del Mezzogiorno tra crisi pandemica e diritto alla salute
E’ stato un anniversario sottotono quello dei 160 anni dell’unità d’Italia. Il virus morde ancora e al centro del discorso pubblico rimangono, prevalentemente, il bollettino quotidiano di contagi, ricoveri e morti e la campagna di vaccinazione che va a rilento, il problema dei ristori per le categorie più colpite dalla crisi. A ben vedere, tuttavia, proprio la pandemia, con i suoi risvolti economici e sociali, dovrebbe imporre, ad ogni livello, una riflessione adeguata sugli squilibri territoriali che ancora persistono nel nostro Paese. A dispetto di quarant’anni di intervento straordinario nel Mezzogiorno (1950 – 1993) ed oltre trenta di “politiche di coesione” implementate con fondi strutturali europei.
Emblematico il caso della Calabria, dichiarata zona rossa lo scorso mese di novembre non per il numero dei contagi ma per la sua sanità allo sbando. E’ stato uno scossone forte. I calabresi si sono sentiti di colpo come topi in trappola. La certificazione di un immane disastro. Ma nelle settimane e nei mesi successivi non si è fatto quasi niente per rimediare, almeno, alle criticità più acute del sistema. Dopo il balletto dei commissari, siamo alle classifiche imbarazzanti che danno la Calabria all’ultimo posto per vaccini effettuati e, ancora, per posti di degenza e di terapia intensiva disponibili. Calabria punta dell’iceberg, comunque. Perché il problema del divario sanitario riguarda tutto il sud, dove si concentrano, peraltro, tutti gli enti commissariati (Calabria e Molise) e quelli sottoposti a piani di rientro dal debito (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise Puglia e Sicilia). Il risanamento in danno del diritto alla salute. Come se la vita fosse una merce qualsiasi. Lo dicono i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), per niente omogenei su scala nazionale. Posti letto, personale, attrezzature medicali: c’è un abisso tra nord e sud. Il che spiega anche il fenomeno, triste e doloroso, della migrazione sanitaria dei malati del sud verso le strutture del nord. Migrazione di pazienti, spostamento di risorse finanziarie verso le aree ricche del Paese (4,6 miliardi nel 2018, a fronte di un milione di pazienti). Vecchia storia quella dei soldi del sud che arricchiscono il nord. Un secolo fa Gramsci parlava dell’«emigrazione di ogni denaro liquido dal Mezzogiorno nel Settentrione per trovare maggiori e più immediati utili nell’industria». Un marchio di fabbrica della nazione.
Intanto dalla Calabria, e dalle regioni meridionali, si continua a fuggire. Negli ultimi quindici anni sono stati più di due milioni i cittadini del sud che hanno fatto la valigia, verso le regioni del nord ed altri Paesi europei. Giovani, soprattutto. Un esodo silenzioso che sta svuotando paesi e territori. Ne risente pesantemente l’economia di questi luoghi. Silenzio, vuoto, declino, abbandono, decrescita per niente felice. Si stima che da qui al 2065 la popolazione italiana si ridurrà di circa sette milioni di persone. Ma di questi, più di cinque mancheranno nel Mezzogiorno. Un quadro tendenziale drammatico su cui, nell’ultimo anno, si è abbattuta in maniera molto violenta la crisi pandemica. I numeri della Svimez sono molto forti a tal riguardo. 280 mila posti di lavoro persi e una contrazione del Pil del 9% (maglia nera la Basilicata, con un traumatico -12,9%). La crisi è nazionale, ma al sud ha fatto esplodere contraddizioni preesistenti. Ha aggravato gli squilibri tra le due economie del Paese. «II Covid-19 non è stato una “livella”, non ha reso tutti un po’ più poveri ma più uguali. Gli andamenti più recenti sul mercato del lavoro mostrano l’esatto contrario: la crisi seguita alla pandemia è stata un acceleratore di quei processi di ingiustizia sociale in atto ormai da molti anni che ampliano le distanze tra cittadini e territori», si legge nel Rapporto 2020. Impatti solo in parte mitigati dal Reddito di Cittadinanza, che comunque ha contribuito «a ridurre la platea dell’esclusione e della marginalità fornendo un reddito minimo garantito». Il futuro? Due velocità anche nella capacità di ripresa. Quest’anno e l’anno prossimo, se tutto andrà bene, il sud crescerà dell’1%, mentre le regioni del nord almeno del 5%. Una prospettiva insostenibile.
La crisi pandemica, come tutte le grandi crisi, potrebbe nondimeno essere colta come opportunità per un’inversione di tendenza. Rispetto alla crisi precedente l’approccio delle istituzioni nazionali ed europee è cambiato. Per il momento il debito non costituisce un problema, la Bce lavora bene per garantirne la stabilità e la solvibilità, addirittura si è fatto ricorso agli eurobond per finanziare il Next Generation UE. Per quanto riguarda il nostro Paese, in un anno sono stati fatti circa 130 miliardi di debito aggiuntivo per fronteggiare l’emergenza e duecento miliardi di euro dovrebbero arrivare da Bruxelles nei prossimi sette anni. I soldi ci sono, insomma. Rimane il problema di come questi soldi si vogliono spendere e per chi. E se al centro della strategia del governo il Mezzogiorno c’è oppure no. Il nuovo presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha detto nel suo discorso al Senato che l’impianto del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) approntato quando a Palazzo Chigi c’era Conte non dovrebbe subire grandi modifiche. In attesa di leggere la versione finale di questo documento, siamo costretti, quindi, a rifarci alla bozza già esistente. E, soprattutto, alla filosofia di fondo che la informa, che così si può sintetizzare: la crescita economica del Paese, negli ultimi vent’anni, è stata «nettamente inferiore» alla media europea e, su scala globale, a quella delle altre economie avanzate. Per uscire dalla nuova crisi, quindi, recuperando anche il gap con le altre economie più forti del pianeta, c’è bisogno di investimenti, incentivi, misure di semplificazione e un’opera di ammodernamento degli apparati produttivi (innovazione tecnologica, digitalizzazione) che stimolino la competitività del sistema Paese e facciano aumentare la produttività del lavoro. Con queste premesse, ci vuole poco a capire che la gran parte delle risorse disponibili rischia di essere assorbita dall’economia del nord, dove ha sede il motore economico del Paese e insistono le imprese maggiormente integrate nelle catene europee e globali di produzione di valore. Potrebbe accadere, insomma, che la “cura” del Recovery plan, anziché avviare a risoluzione le «disparità territoriali» che hanno segnato la storia d’Italia dalla sua fondazione, allarghi ancora di più il fossato tra nord e sud e rinfocoli le aspirazioni separatiste delle regioni più ricche del Paese (il dossier dell’autonomia differenziata è tutt’altro che chiuso).
Eppure, con i parametri individuati dall’Unione per l’attribuzione delle risorse di Next Generation UE (disoccupazione, reddito pro-capite, popolazione, perdita cumulata di PIL), più della metà delle stesse dovrebbero essere convogliate verso il Mezzogiorno (evitando di inserire nel Piano opere già finanziate con altri fondi). Per restringere la forbice infrastrutturale tra regioni meridionali e settentrionali e tentare una manovra di riallineamento dell’economia del Sud a quella delle regioni europee maggiormente sviluppate, nell’ottica del rafforzamento della coesione territoriale in ambito Ue. In concreto, si tratterebbe di utilizzare una fetta importante di queste risorse per colmare il gap di reti stradali, ferrovie veloci, infrastrutture portuali e autostrade del mare che attualmente impedisce all’economia meridionale di affermarsi sullo scacchiere europeo e globale e per progetti di rigenerazione economica e sociale delle aree interne, a cominciare da quelli basati sull’accoglienza.
Ma non solo. E’ assolutamente velleitario pensare di rafforzare il tessuto produttivo delle regioni meridionali con politiche di incentivi (a questo sono destinati i 4,47 miliardi di React-Eu). Non è con lo sconto sui contributi previdenziali che si possono incentivare gli investimenti privati in aree depresse e prive di infrastrutture logistiche adeguate. Sono strade già battute che, insieme ai finanziamenti a pioggia, non hanno prodotto mai nessun risultato. Per questo, accanto agli investimenti pubblici nelle infrastrutture, servirebbe un nuovo ruolo imprenditoriale dello Stato. Non una replica delle “cattedrali nel deserto”, beninteso, ma una rinnovata funzione strategica del capitale pubblico, da esplicarsi nel quadro di nuova programmazione economica nazionale. Il Sud potrebbe essere non solo la sede d’elezione di un’intrapresa pubblica in settori altamente innovativi e tecnologici (farmaceutica, biomedicale, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, tecnologie applicate al marketing dei prodotti turistici, aerospazio), capace di offrire know how alla manifattura più tradizionale del nord, ma anche un anello imprescindibile della catena del valore nazionale ed europeo. Un Sud con una sua specializzazione produttiva, più equo, per un’Italia più competitiva nel Mercato unico e nel nuovo scenario internazionale che ci lascerà in eredità la pandemia.