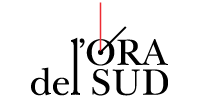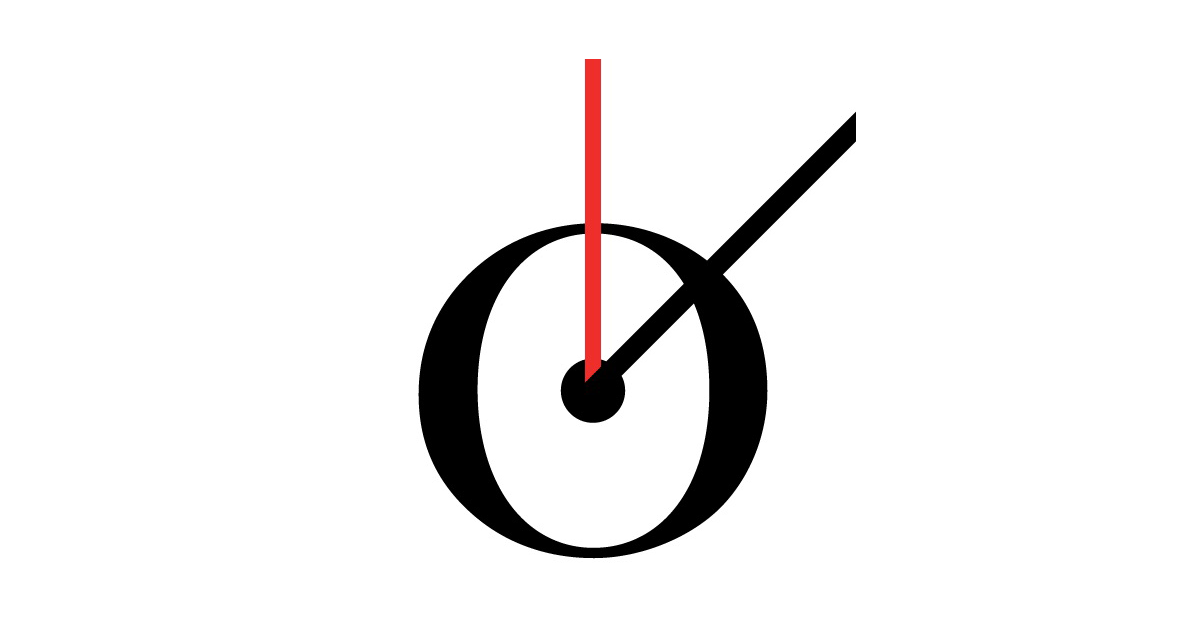Ma che musica maestra
FABIO FALABELLA
Un'immagine del direttore Venezi allo scorso Festival di Sanremo
Amadeus Mozart: requiem di un Festival e della Lingua Italiana
Al netto della classifica finale della 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana, posticipata per l’emergenza da Covid 19, andata in scena nella settimana che volge al termine e che ha visto trionfare il gruppo rock romano dei Maneskin, salito alle luci della ribalta già prima degli onori del palco dell’Ariston grazie al noto talent show “X factor”, anche quest’anno, l’evento più popolare della televisione nostrana ha fatto registrare alcuni spunti che, a mio parere, appaiono significativi e sui quali, su di uno in particolare, mi pare opportuno indugiare oltre per qualche istante, anche dopo la consegna del fatidico e prestigioso Leone d’oro ai quattro capitolini emergenti in tuta rosa e merletti da pigiama party. Pur avendo seguito negli anni scorsi la kermesse da inviato di alcune testate giornalistiche locali e nazionali, ma non avendolo guardato, quest’ultimo, da spettatore attento, non mi soffermerò su giudizi di natura squisitamente tecnica, che, nel caso di specie, non mi pertengono e che non sarei titolato ad esprimere. Ad una semplice occhiata, lanciata velocemente, mi pare del resto di aver colto alcuni segnali significativi, taluni in apparente contraddizione, che sono pervenuti inesorabili dalla città dei fiori, sui quali argomenterò brevemente nelle righe che seguono, per indirizzare in seconda battuta la mia attenzione, e quella dei nostri lettori, sul punto centrale di questo articolo. Innanzitutto, il festival più visto di sempre via social è quello che ha fatto registrare la percentuale minore di share, intesa in termini di pubblico televisivo, tra quelli dell’ultimo decennio, con buona pace della rodata coppia Amadeus-Fiorello e senza giudizi di merito sui conduttori o le conduttrici delle edizioni precedenti. Il successo tributato dalla rete, anche grazie al contributo offerto dal canale digitale Rai Play, si spiega in realtà con la crescente tendenza dell’ascolto di musica in streaming, che è stata certificata dagli addetti ai lavori e dagli esperti del settore e cui si stanno adeguando le grandi major e le case discografiche più importanti sulla scena internazionale, offrendo, a pagamento s’intende, concerti dei loro cantanti e musicisti suonati sovente all’interno di mura domestiche o di location comunque alternative allo studio di registrazione, fino a chi si è spinto addirittura a promuovere eventi virtuali anche con avatar appositi attraverso le piattaforme di “play gaming” più frequentate dagli adolescenti di mezzo mondo, si vedano in tal senso gli esempi di Travis Scott, Ketame o dei Massime Attack. Per altro verso, quello che, qualche anno fa, Claudio Baglioni voleva tornasse ad essere il festival della canzone italiana e delle canzonette pop, è apparso in questa edizione piuttosto un grande show, sebbene con le poltrone della platea vuote, durante il quale performances artistiche di un certo livello si sono alternate a momenti di dubbio gusto e poco coinvolgenti, che presupporrebbero una certa cautela a parlare di successo, come invece, ma è comprensibile, si sono affrettati a fare i vertici Rai nei giorni passati e nella conferenza conclusiva, tenuta, come di consueto, in una delle più belle ed affascinanti tra le sale stampa presenti nel nostro Paese, che ho avuto la fortuna e l’onore di visitare e frequentare. Detto questo, va rilevato però che per alcune serate , ciò che più ci interessa in questa sede, il dibattito nostrano di tanti esperti virologi e tuttologi, divenuti in un batter d’occhio critici musicali prima e ferrati linguisti poi, si è concentrato sulla frase ad effetto pronunciata da Beatrice Venezi, che, annunciata alla direzione dal presentatore prima di una delle interpretazioni tra quelle in gara, ha preferito, pur essendo donna e, immagino, capace, consapevole ed emancipata, farsi chiamare direttore d’orchestra, con la parola, a mio avviso opportunamente, declinata al maschile, nella forma classica. Ne è venuto fuori un polverone insensato, trasformatosi in alcuni frangenti in un putiferio, uno scontro tra presunti guelfi ed altrettanto indimostrabili ghibellini dell’affrancamento civile e culturale, come avviene spesso alle nostre latitudini, tra favorevoli e contrari alla esternazione della Venezi. Mi piace sottolineare, a poche ore dalla giornata dedicata alla festa della donna, un’altra celebrazione che spesso ed ahimè scade solo in un rituale vacuo e fuorviante, buono per fare scempio di mimose dagli alberi in fiore e far aumentare le vendite dei vivaisti, che la scelta linguistica del direttore nulla ha a che vedere con la tutela dei diritti delle donne, con il rispetto delle differenze di genere, né tanto meno col favorire o precludere un processo di emancipazione acculturante della nostra, da questo punto di vista arretrata, società. Mi ha sempre fatto sorridere, e suscitato dubbio, sensazioni di inadeguatezza e disapprovazione, chi nella vita ha inteso arrogarsi il diritto di combattere battaglie significative ed irrimandabili semplicemente appuntandosi una spilletta in petto, come fossimo al club di Topolino o delle giovani marmotte. Ogni lingua, ed anche la nostra, del resto, ha le sue proprie regole grammaticali, le sue declinazioni, che eludono, preesistono ed eccedono le schermaglie politiche da bar come quella registrata sull’argomento in questione. Né l’avanzamento delle donne, di quello che ancora, improvvidamente e maldestramente viene chiamato il sesso debole da qualcuno, può essere associato, stimato e valutato dalle desinenze terminologiche di uso comune e non, sebbene, come recitava Nanni Moretti in un suo celebre le film, le parole siano importanti, cosa di cui sono assolutamente conscio e convinto. La polemica specifica, come altre, mi è apparsa nondimeno forzata, stucchevole e strumentale, discriminante da una prospettiva completamente ribaltata ed inversa proprio per le ragioni appena espresse, al pari del dibattito pluridecennale in corso in Italia sulla questione delle cosiddette “quote rosa”, che dovrebbero favorire, quasi mai ci riescono pienamente, una presenza paritaria delle donne o più equilibrata tra i sessi nelle istituzioni, presupposto della doppia preferenza che ci viene offerta come possibilità, in quanto elettori, nelle consultazioni di ogni ordine e grado da disposizione normativa. Ed in effetti accade, è successo anche con Maria Elena Boschi di Italia Viva, che ebbi l’occasione di intervistare nel corso di una inaugurazione di un centro di accoglienza in Basilicata per donne vittime di violenza, principalmente domestica e subìta da parte dei loro mariti o compagni, che i vari partiti alle elezioni politiche ed europee scelgano una capolista donna in diverse circoscrizioni salvo poi, per effetto della rinuncia e della scelta obbligatoria di uno solo tra i seggi in palio, attribuire i restanti a candidati di sesso maschile, opportunamente piazzati in seconda posizione dietro colei che, facendo solo da apripista, finisce per fungere esclusivamente da specchio per le allodole e, paradossalmente, per ledere alla stessa causa di cui si fa simbolo, icona e promotrice. Non potrebbe essere altrimenti, a dire il vero, in un contesto in cui le donne faticano enormemente ad affermarsi ai vertici apicali della sistema economico e sociale, sebbene percentualmente lavorino meglio, di più e più efficacemente degli uomini, a fronte di salari quasi sempre inferiori e talora persino dimezzati: ne sia testimonianza, per citarne una, la mancanza assoluta di scienziate nel consesso di luminari del CTS che sta gestendo la crisi sanitaria dovuta alla pandemia consigliando ministri e sottosegretari, completamente privo di qualsiasi fiocco rosa alla porta di ingresso. L’argomento è delicatissimo e spinoso, perciò non andrebbe banalizzato con schermaglie da bar del tutto infondate ed inconsapevoli, basate quasi esclusivamente su disinformazione e mancanza di cognizione del tema discusso. Giudizio che mi pare valido tanto più se riferito a problemi di natura linguistica: secondo quanto riportato dall’Ansa e dall’Huffington Post, infatti, “ognuno ha il diritto di essere chiamato come vuole nella pluralità degli usi esistenti della lingua italiana” senza che ciò pregiudichi, aggiungo, la sacrosanta lotta per l’affermazione delle donne nella nostra società. Perché “scegliendo la definizione di direttore – ha spiegato il professor Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia della Crusca – Beatrice Venezi ha adoperato un maschile inclusivo o non marcato. Una soluzione tradizionale – continua Marazzini – ben nota alla lingua italiana e che viene considerata tuttavia come una bestia nera da taluni, perché a loro giudizio non riconosce o occulta gli avanzamenti del dibattito di genere. Sul piano propriamente lessicale – conclude il presidente dell’Accademia della Crusca – Beatrice Venezi aveva tre possibilità per definirsi: una più tradizionale (direttore) che però taluni accusano di essere ideologicamente arretrata; una declinata al femminile (direttrice) ed una più innovativa (direttora) – che l’editor di testo utilizzato per questo editoriale segna addirittura in rosso come errore (sic!), ndr. Seguendo la logica dei taluni evocati da Marazzini, in fondo, anche parole come giudice, o arbitro, per utilizzare un termine di uso sportivo e simile funzione, andrebbero bandite dal dizionario per l’altra metà dell’universo, espressione anch’essa poco felice (sono di più le donne e probabilmente, considerati gli orientamenti sessuali di ciascuno e ciascuna, non esistono solo due metà sopra l’Olimpo degli umani), per coniare in sostituzione ed al loro posto obbrobri cacofonici del tipo di arbitra e, perché no, giudicessa. Mi consola pensare che, quantomeno a livello verbale, il Greco antico aveva risolto la querelle già circa tremila anni fa con l’uso del modo del duale, quello sì onnicomprensivo di qualsiasi sfumatura possibile, davvero senza distinzione di genere. Nella nostra epoca sgrammaticata e qualunquista, incolta ed approssimativa, dove valgono le affermazioni più inverosimili e strampalate, per trovare una soluzione adeguata mi sentirei provocatoriamente di proporre le quote rosa anche per sostantivi ed aggettivi, di modo che, in qualsiasi vocabolario, i lemmi terminanti con desinenze al maschile non superino mai di una certa quota quelli al femminile, e viceversa. E così per un bagno ci vorrebbe una “bagna”, per un lavandino una “lavandina” o per un pastello una “pastella” e via discorrendo. Utilizzando questo metodo, allora sì, avremmo una società più giusta e rispettosa delle identità, delle differenze, delle singolarità, delle inclinazioni individuali e delle diversità.